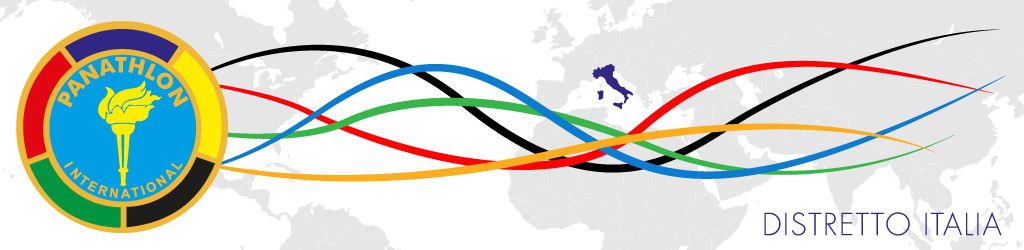I protagonisti della letteratura sportiva

di Federica Zaniboni
Diego Alverà è uno che racconta storie. In senso buono, certo. E anzi, nel senso più nobile del termine. La sua professione è trasmettere al pubblico ciò che di più importante è riuscito a catturare dalle vite degli altri: per farlo si serve di tutti gli strumenti che ha a disposizione, dalla carta stampata al podcast, dai social media alla narrazione dal vivo. Sport e musica – che da sempre appassionano lo storyteller veronese – rappresentano per lui una continua ed immensa fonte di ispirazione.
«Alle spalle ho un percorso abbastanza irregolare, mosso molto di più dall’istinto che dagli studi» spiega Alverà, 55 anni. «Fin da bambino ho una spiccata attitudine a un certo tipo di comunicazione: a soli quattro anni mi diverto a ritagliare articoli e foto dai quotidiani per poi metterli insieme a ricreare il mio piccolo giornale». Un primissimo passo al quale poi ne seguono, con naturalezza, molti altri nel corso del tempo. «Comincio a lavorare nel settore musicale, soprattutto in radio. E un po’ alla volta, avvicinandomi ad alcuni testi, scopro la voglia di raccontare le storie che mi porto dentro» sottolinea. Il teatro, poi, è il passaggio successivo. O meglio, la finestra che gli permette di ampliare lo sguardo a un mondo nuovo. «Nel 2009 firmo un monologo dedicato a Verona-Milan del 1973. Ma solo in parte si parla della partita: l’obiettivo è quello di mettere in luce una precisa idea di calcio, una promessa che questo sport aveva fatto alla mia generazione» dice. «Il lavoro, però, nel complesso non mi soddisfa. Non mi piace l’enfasi che il teatro mette nelle parole, e capisco che ho bisogno di un ambiente diverso».

Così Alverà trova presto la giusta chiave per offrire al mondo quella forte necessità di comunicare – servendosi del palco, sì, ma lasciando da parte la recitazione. «Comincio a raccontare alla mia maniera, facendo tesoro di tutte le esperienze accumulate in passato, anche quelle legate ai suoni». Una nuova scoperta che in poco tempo si trasforma una serie di lavori radiofonici e che successivamente lo fa avvicinare al mondo del podcast – «inizio a farli dieci anni prima che diventino una moda» -, fino a che Alverà diventa direttore editoriale della casa di produzione Storie Avvolgibili. Ma come lui stesso tiene a sottolineare, «lo storytelling, in realtà, non ha nulla a che vedere col raccontare una storia». E la narrazione dal vivo, in particolare, va a toccare una sfera molto più intima e personale nel rapporto tra il pubblico e colui che racconta. «Significa soprattutto affidare qualcosa a qualcuno», e le vite di personaggi come musicisti e atleti sono spesso il suo punto di partenza.
«Bisognerebbe chiedere alle persone cosa vedono nello sport» afferma. «Io sono cresciuto in anni in cui si diceva che era una metafora della vita, definizione che ho sempre trovato odiosa e pleonastica. Lo sport è la vita, la piccola grande missione di noi esseri umani che cerchiamo sempre di migliorarci e superare i nostri limiti». Ma le due grandi tematiche che predilige quando parla sul palco sono la velocità – «una delle mie passioni più profonde» sottolinea – e l’esplorazione. «Vado a caccia di storie che mi ispirino, che mi trasmettano grandi emozioni o che lascino un messaggio. Questo è quello che cerco sempre di proporre anche nei libri».
Già, la scrittura. L’altro importante mezzo di comunicazione, oltre alla voce, di cui Alverà si serve per portare al pubblico le sue parole. «Sono tutte competenze molto diverse tra loro: il podcast è la vera frontiera creativa, un terreno di espressione straordinario» spiega. «Entrare nelle cuffie della gente crea una grandissima intimità. Il palco, invece, permette di essere anche carne, suono, movimento… D’altra parte, la letteratura resta la più grande macchina virtuale di immaginazione del mondo» continua. «La potenza evocativa di un testo scritto è ineguagliabile».

Il mese scorso è uscito Idoli – Guida sentimentale di un calcio romantico, l’ultimo volume firmato da Diego Alverà e pubblicato da Edizioni della sera. Un titolo accattivante e al tempo stesso inequivocabile. Come sottolinea l’autore, «in antichità gli idoli erano simulacri da adorare, divenuti poi dei simboli grazie alla cultura pop. E in questo senso, la figura dello sportivo occupa uno spazio molto grande nell’immaginario collettivo». Ecco gli idoli, dunque, di cui si parla nel libro: 22 calciatori – tra cui George Best, Garrincha, Gigi Riva, Gianni Rivera e Johann Cruyff – visti attraverso uno sguardo nuovo e mai superficiale. «A loro ho voluto dedicare queste pagine, mettendo a disposizione dei lettori ciò che in un modo o nell’altro mi hanno lasciato» sottolinea. «Non ci sono biografie, soltanto i momenti decisivi delle loro carriere, che molto spesso coincidono con il dubbio, le cadute e le incertezze. Ho capito che i fallimenti fanno crescere più del successo, e ho deciso di raccontare le difficoltà personali, il peso delle aspettative, e il modo in cui tutti questi personaggi ne sono venuti fuori».
Da qui, la definizione di “calcio romantico” riportata nel titolo del volume. Un concetto che senza dubbio si rifà a quello più ampio di letteratura sportiva, nel quale Diego Alverà ricopre un ruolo ben preciso. «Allo sport non chiedo il risultato o l’atto fisico in sé, ciò di cui mi occupo è un’altra cosa» sottolinea. «Per me è un pretesto per raccontare l’essere umano». E all’interno di un contesto decisamente limitato rispetto ad altri paesi europei – «qui c’è ancora il pregiudizio che chi si occupa di sport lo fa per passatempo personale, senza che venga riconosciuto nessun valore culturale» dice –, i grandi nomi non sono certo mancati. «Abbiamo avuto una generazione straordinaria di giornalisti sportivi, come Gianni Brera o Adalberto Scemma, che sono riusciti a rivendicare la dignità della professione, creando un linguaggio nuovo per parlare del settore. Adesso, però, l’atleta non è più accessibile come una volta» aggiunge. «Questo lavoro ormai è diventato un po’ quello del passacarte: il più delle volte devono dar vita e fantasia a un comunicato stampa che in fondo è sempre quello, senza la possibilità di fare la domanda giusta al giocatore».
E quindi sì, Diego Alverà è uno che racconta storie nel senso più nobile del termine. E su questo sfondo amplissimo nel quale si trova perfettamente inserito, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. «Se non fosse stato per i social media, non so nemmeno se avrei mai cominciato a scrivere» confessa. «Dieci anni fa faccio una scommessa con me stesso e decido che ogni giorno apro il mio laptop a mezzanotte, scorro i nomi delle persone nate o morte il giorno successivo, e poi scrivo di loro su Facebook. Così per quasi due anni». E come sottolinea infine lo scrittore, anche in quel caso non c’era spazio per le biografie. «Mi occupo di lasciti, facendomi portavoce delle storie che queste persone ci hanno affidato».