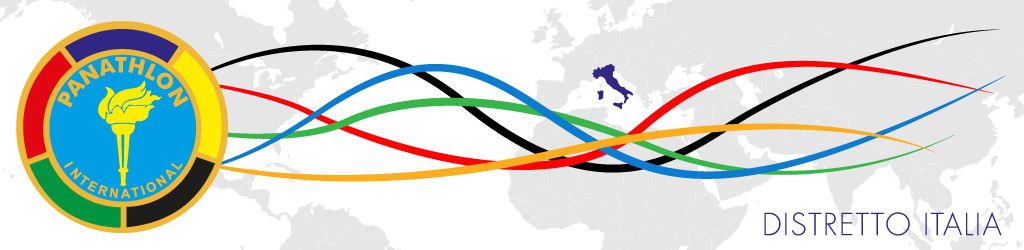“IO TIFO PERCHE’ ” di Alberto Brambilla
Ad un tratto apparvero alcuni giocatori, l’Inter con la solita maglia nerazzurra, gli avversari con una maglia a me stranamente familiare. In quel preciso momento irruppe la voce del telecronista che descriveva la maglia del Celtic, definendola “a strisce orizzontali…tipo Pro Patria”.
Una locomotiva simpatica e qualche vagone carico di legname, ciù ciù ciù. Ma qui non è Rio Bo, e l’ombra oscura della torre dello Spielberg ce lo ricorda. E il ron ron di fondo della raffineria, gattona nera accovacciata, sembra confermare l’impossibilità di oltrepassare la frontiera. Neppure con lo sguardo.
Ora d’aria, finalmente. Non c’è niente di meglio che scendere – in fila per due e ricordatevi che non si può parlare! – ai prati nella valle. Quattro campi da calcio. Porte in ferro, color ruggine. Campi da sette o da nove, ma si gioca anche in undici contro undici, e si può arrivare ben oltre. Qui si può parlare e correre e giocare. A pallone, naturalmente.

Sfide accese in cui si mette in palio il proprio orgoglio, e non solo. Qui in Lombardia i ragazzi nati a metà degli anni Cinquanta tifano solo per gli squadroni: Milan, Inter, Juventus. Poco altro, e non conta. In questa valle di lacrime, giocare è vivere. Anche se a volte, d’inverno, scende una nebbia fradicia e il freddo ti costringe a subire stilettate a cominciare dalle spalle e poi giù, correndo sul filone della schiena. Maglietta di cotone. Pantaloncini corti d’ordinanza. Guanti verboten. Sebbene nella massima estensione, i calzettoni non arrivano al ginocchio. Restano venti-trenta centimetri scoperti. Se non corri muori assiderato.
Qui da noi contano solo gli squadroni. Quando parlo di Pro Patria, nei primi anni Sessanta, mi guardano come fossi un marziano. Ma io tengo duro, è quella la mia squadra, la squadra di mio padre e dei miei avi. L’ho vista una volta sola prima d’essere rinchiuso a dieci anni. Pro Patria Napoli 2-2, doppietta di un certo Canè, non so se mi spiego. Fu il primo impatto con un vero ‘negretto’, ma questa è un’altra storia. Capivo poco di football, ma quella maglia a strisce orizzontali non l’ho mai dimenticata. Unica.
Duelli all’ultimo sangue. È l’Inter la squadra da battere, in Italia e nel mondo. Quasi tutti i ragazzi qui stravedono per i nerazzurri. È l’unica libertà concessaci, di scegliere la squadra che ci terrà un po’ di compagnia. Perché i giorni e le notti senza i genitori sono difficili, lo sai?
Sotto la statua del Curato d’Ars si sussurrano giaculatorie oscene. E all’ombra degli alberi o negli angoli bui dei cessi si scambiano le prime figurine. Quelle dell’Inter sono le più ricercate. Sarti-Burgnich-Facchetti pregate per noi. Il beato Luisito ci protegga e l’Angelo Domingo sia sempre a noi vicino.
All’arma bianca sono i duelli, soprattutto quelli del sabato, quando al pomeriggio non c’è scuola. Allora la valle non è più solo di lacrime e si anima di energie e pulsioni a stento trattenute. Da una parte chi tifa per l’Inter, dall’altra una squadra mista Milan-Juventus, per una volta quasi fratelli. Ma senza esagerare.
Non sono male io, anzi. E chi mi ha visto giocare lo può testimoniare. D’altronde non sono molte le possibilità per sopravvivere all’aridità dei sentimenti. Ala o mezzala, meglio a destra, ma se occorre gioco a sinistra. Inseguire un pallone di gomma piena e dura è la sospensione del dolore, l’anestesia più dolce che abbia mai provato.
Ma tradire no, non è possibile. Inter, Juventus e Milan per me pari sono. Mi fanno schifo, anzi non esistono proprio. Io ho in testa la Pro Patria e delle figurine Panini ho nel mio armadietto solo quella di Enrico Muzzio. È l’unico ex della Pro Patria nella collezione 1966-67, ed ora gioca nella Spal.
Io sono nato a Busto Arsizio undici anni fa, non posso tradire. Neppure Sant’Antonio dalla barba bianca me lo può chiedere, neppure padre Ignazio. Così mi autoescludo. E non c’è niente di più triste di pomeriggi come questi. Passati in piedi, freddo fuori e gelo dentro. Si scannano dietro un pallone i miei fratelli, ma io sono diverso. Ora me ne accorgo.
Mi presto a fare il raccattapalle, per muovermi un po’ e stordirmi. Ma quando la sfera vola fuori campo, dopo i primi arbusti e il rivo strozzato e maleodorante dell’Olonella…Allora ho come uno stordimento. Vacillo, annaspo. Fingo di non ritrovare il pallone, ma l’ho già in mano e faccio di nascosto due o tre palleggi. Dietro i rovi.
Mi chiamano. Pretendono di giocare gli stronzi, i fortunati. E anch’io lo potrei, se solo dichiarassi la mia fede, in fondo sarebbe la mia seconda squadra. Non tradirei nessuno. No, non posso. Avvinghiarmi con le unghie a quel vecchio albero, alla Pro Patria intendo, è un modo per crescere di dentro, è un modo per non morire senza identità.
Ma ora non posso più sopportare la visione di quelle maglie variopinte che si mescolano e s’azzuffano e si allontanano senza una logica apparente. Non c’è niente di più triste di pomeriggi come questi, passati a contemplare l’altrui felicità.
Woow woow ciù fa il Gibuti, woow woow, woow woow ciù ciù ciù. Per un attimo l’incontro si interrompe e io posso ritornare come gli altri, partecipe del medesimo destino. Ciao Africa, addio. Si allontana il treno e tutto passa, tutto se ne va. Anche il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore. Ma questo l’avrei capito anni dopo. Woow woow, woow woow ciù ciù ciù.
Si avvia probabilmente ad una nuova vittoria, l’Internazionale di Milano. Che è tallonata da una sorprendente Juventus. Sarà quel che sarà. A me poco o nulla importa e lo confesso alla figura austera di Dante Alighieri, dipinta alle pareti del cortile centrale del Collegio, insieme agli altri grandi. Sono ventidue, come dire due squadre di calcio.
Sono visioni, allucinazioni mentali di questa tarda primavera che finalmente ha invaso il mondo e scaldato la prigione.
Mese di maggio, mese delle rose. E della mistica e vera Rosa, mese della Madonna, come ci ripete ossessivamente padre Ignazio. Per noi mese in cui si decide il campionato, mese della resa dei conti. La spavalda e anzi superba Inter è chiamata ad un’altra finale nella Coppa dei Campioni. Sarà Lisbona la città designata, il Celtic l’avversario.
Senza farmi vedere dai compagni, guardo in classe sulla carta geografica dov’è Lisbona, un punto nero sull’arancio-Portogallo. E devo salire sulla sedia per raggiungere la verde Scozia, so già che il Celtic è la squadra di Glasgow.
“Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio, dei primi fanti il 24 maggio”. Ma nella mia storia personale è il 25 maggio il giorno fatale, anche se allora non lo potevo sapere. Lisbona, 25 maggio 1967, finale Inter-Celtic. L’insolita generosità di padre Ignazio, sollecitata da pressioni nerazzurre di varia provenienza ma di sufficiente intensità, ci concesse di vedere quella sera alla TV lo scontro tanto atteso.
Ma non da me. Che fui obbligato – tacere bisognava e andare avanti – a restare coi compagni in refettorio per assistere all’incontro. L’occhio semidivino si ergeva in un angolo, scatolone di vetro e legno sorretto da lunghe leve metalliche. Io attendevo l’evento con curiosità e fastidio, anche se era comunque un diversivo rispetto all’ora di studio obbligatorio, e all’oretta passata finalmente nel cortile, ad ascoltare il ronfare lontano della gatta-raffineria, pensando ai fatti miei.
Dopo ripetuto scatarrare seguito all’accensione (e alla non corretta sintonia), lo scatolone incominciò a vomitare immagini, anzi ectoplasmi luminescenti. Infine padre Ignazio con l’ausilio forse di santa Maria Goretti, o comunque di un influente spirito, riuscì a catturare le prime immagini. Mancavano pochi minuti al collegamento.
Sulle sedie di legno e metallo aspettavamo in sofferto silenzio il calcio d’inizio. Era comunque quello un giorno speciale. Una piacevole eccezione rispetto ad una vita regolata dagli altri. Tornavamo per un momento padroni del nostro tempo, o almeno così ci sembrava. Infine ecco il collegamento, accompagnato da un brusio di tensione e di ammirazione per lo scatolone magico che ci trasferiva a Lisbona.
Mentre scorrevano le prime immagini in bianco nero, non molto nitide, a causa della lontananza dell’evento, mi parve di intravedere un lungo striscione con la scritta BUSTO ARSIZIO, collocato proprio sopra le panchine degli allenatori. Ebbi come un mancamento. Dietro a quel nome c’era un grumo d’affetti, una storia, le radici, la lontananza. Ma fu solo un lampo e forse fu frutto della mia eccitazione o della stanchezza.
A quel punto subentrò la voce di Nicolò Carosio, l’aedo per eccellenza, l’Omero prediletto. Incominciava ad inquadrare la partita, dando le formazioni delle squadre. Ad un tratto apparvero alcuni giocatori, l’Inter con la solita maglia nerazzurra, gli avversari… con una maglia a me stranamente familiare. In quel preciso momento irruppe la voce del telecronista che descriveva la maglia del Celtic, definendola “a strisce orizzontali…tipo Pro Patria”.
“Tipo Pro Patria!”, “Tipo Pro Patria!” ripetevo come una giaculatoria-scioglilingua. Qualche compagno mi guardò all’improvviso, io dovevo apparire loro come un San Luigi di luce incoronato. Mi mordevo le labbra stringendo i pugni sotto il lungo tavolo di formica verdolina. Allora ebbi un’illuminazione e poi una certezza: mai e poi mai avrebbe vinto l’Inter contro la mia Pro Patria miracolosamente trasferita – non era accaduto qualcosa di simile a Loreto ? – in terra scozzese. Mai.