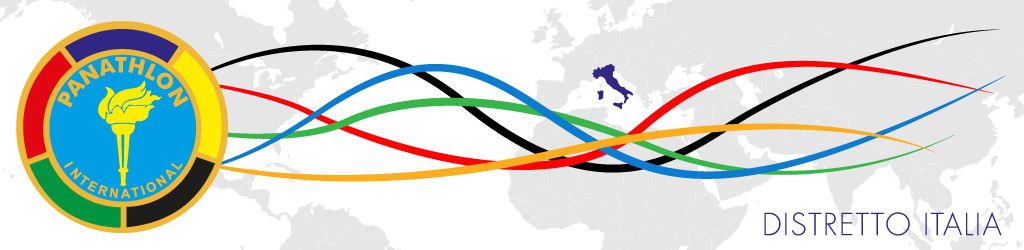-Tanto per evadere dall’assillante monotonia di questa quotidianità coatta, lasciando da parte eccezionalmente per un attimo lo sport, vi racconto di un mio viaggio a Mosca, allora capitale dell’Unione Sovietica, siamo infatti nel 1965, in occasione dell’1 maggio. Non una Mosca rutilante di luci e di gente indaffarata per le strade come oggi si vede, ma una Mosca triste e dimessa che rispecchiava l’insuccesso della Realpolitik comunista.
di Massimo Rosa

All’improvviso due Mig con la stella rossa sulla coda affiancarono il Tupolev a due piani partito dall’aeroporto Malpensa un paio d’ore prima.

Da pochi secondi una voce raccontava che stavamo sorvolando l’Ukraina dove sotto di noi si estendeva il più grande campo di frumento del mondo: 100 km x 100 km, orgoglio dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Guardando sotto dall’oblò poteva essere vero. Ma chissà se era solo propaganda.

Stavo andando a Mosca per assistere alla sfilata del 1° maggio, nel 1965. Avevo aderito ad un programma dell’Italturist, la versione italiana di Inturist, la potente compagnia di viaggi sovietica.
La trasferta nella capitale dell’Urss era a larga partecipazione del PCI. Dalla Malpensa erano decollati 12 Tupolev. Non avevo mai visto né tanti aerei in un solo colpo, né tantomeno tanti entusiasti gitanti con i fazzoletti rossi al collo con la falce martello gialla.
L’idea di andare in quel mondo, che allora per un certo senso mi attraeva, mi aveva entusiasmato.
I miei amici mi avevano dato del pazzo (erano tutti di destra, ed io, secondo loro, andavo controcorrente. Ero in un certo senso un radical-chic, mi piacevano certe idee). Dunque la curiosità da un lato e l’idea di scoprire quel mondo così lontano mi fecero partire per la capitale mondiale del socialismo reale.

Sul Tupolev non c’erano poltrone ma panche di legno che facevano vibrare il corpo in continuazione, una sorta di body-massage infinito. Dunque un arredamento fortemente proletario, eccetto a metà carlinga dove si trovava un compartimento in velluto rosso scarlatto riservato ai notabili di partito sovietici, a noi off-limits.
Con piacere ricordo che le hostess distribuivano caviale ai passeggeri. Ed il sottoscritto, visto che ai “compagni” non era gradito, ne fece una scorpacciata.

I nostri due angeli custodi ci accompagnarono graziosamente sino a destinazione. Una volta atterrati, intruppati raggiungemmo l’interno dell’aeroporto Sheremetyevo, una costruzione grigia che non metteva certamente allegria.
Espletati velocemente i controlli dei passaporti e dei bagagli (eccezionale per quell’epoca): forse perché eravamo i Tovarich in arrivo dall’Italia, un Paese che contava una decina di milioni di simpatizzanti votanti.
Il tragitto in pullman dall’aeroporto all’hotel Ostankino fu una lunga teoria di orrendi palazzi, tutti irrimediabilmente grigi e tristi, frutto di quell’architettura sovietica che avrei rivisto negli anni a venire stringere i centri storici di Praga e Budapest.
Ciò che mi colpi in questo breve tragitto fu una casa o isba di un color verdino-malattia tutta sghemba (non so come potesse stare in piedi). Ma la particolarità che mi balzò all’occhio fu l’antenna della televisione che troneggiava sul tetto: era incredibilmente di legno. E’ un’immagine inverosimile ma vera che non toglierò mai dall’archivio dei miei ricordi.
Nel quartiere di Ostankino troneggiava la torre della televisione, allora in via di costruzione, altissima sino al cielo. L’hotel era anch’esso un grigio casermone dove ad ogni piano c’era un posto di controllo la cui cerbera era una matrioska dal viso duro ed inespressivo.

Fortunatamente si pranzava e cenava nel famoso e centralissimo Hotel Metropol, proprio di fronte al teatro Bolshoi.

Gli ordini impartitici erano severissimi. Ci si poteva muovere solo con la guida. Guai sgarrare. Alle 20 tutti in pullman per il ritorno all’hotel (così sarebbe stato per tutto il soggiorno), tranne il sottoscritto ed altri cinque gitanti nel paradiso del socialismo reale. Così sgattaiolammo fuori dell’hotel ed andammo in giro per le vie del centro. Mi colpì la poca gente (sembrava esserci il coprifuoco) triste che ci evitava con lo sguardo, come mi colpirono i carri armati a guardia della famosa piazza Rossa.

“Niet” ci disse il soldato a fianco del bestione. Non potevamo entrare. Ma così non fu perché trovammo una falla nel loro sistema e così vi entrammo da una stradina laterale.
La piazza Rossa era bellissima, e nessuno, poiché nessuno c’era, ci cacciò via. Fu un primo trionfo della mia incoscienza. Tutto questo avveniva oltre l’orario che la severa guida ci aveva detto, quindi niente pullman perché da un pezzo se ne era andato. Tornati al Metropol vidi fuori dei taxi. Piccolo particolare nessuno aveva i tergicristalli. Dissi agli altri di entrare dentro. Mi avvicinai ai tassinari dicendo loro in un improbabile russo “Ostankino”. Niet fu la risposta. Poiché non demordo facilmente chiesi ancora. Ricevetti una serie di niet, oltre chissà cosa mi dicevano. Fu allora che mi venne l’dea: dalla tasca tirai fuori un pacchetto di Malboro che offrii al tassinaro. Di fronte quell’inattesa grazia il niet si trasformò in “Da”. E come dal nulla sbucarono fuori gli altri cinque tovarich italiani.
Questo fu l’inizio del mio soggiorno nella capitale del Paradiso reale, quello dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. (Parte 1)
Se volete comunicare con PANATHLON PLANET, scrivete a: segreteria.redazione@panathlondistrettoitalia.it