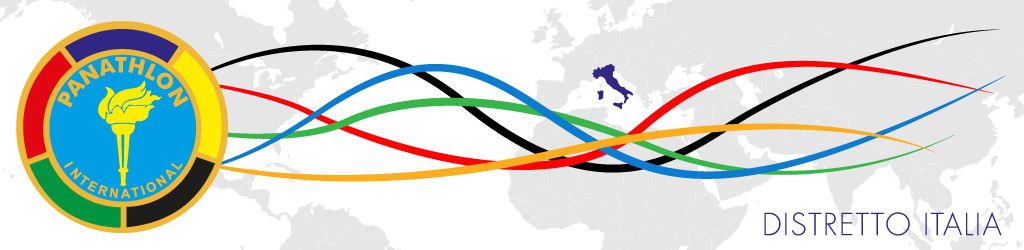-Una “Favola dello Sport” con l’incipit di un campione da leggenda
di Adalberto Scemma
Quando me lo chiedono, quando mi chiedono chi era davvero Pietro Mennea mi viene in mente una sola frase: “Era un visionario. Quindi un poeta”. Per essere poeti non è necessario scrivere versi, ci sono poesie che nascono e vivono senza parole perché è ineffabile tutto ciò che raccontano. Questo era Mennea. Con una visione della vita proiettata sempre più in là, a inseguire sogni evitando però, accuratamente, di tracciarne i confini.
L’ho conosciuto a carriera finita, quando i riflettori avevano smesso di rilanciare immagini troppo nitide. O troppo sfocate. Gli eroi non vivono di luce riflessa. E Pietro non aveva alcun bisogno di enfatizzare storie che l’enfasi di vita, della sua vita, quel suo inseguire tenacemente, rabbiosamente, sogni d’ombra e l’ombra dei sogni, aveva già consegnato alla leggenda.

L’incipit era in un progetto caro a entrambi, una serie di incontri nelle scuole mantovane (a San Giorgio e ad Asola) per raccontare, non ai ragazzi ma assieme ai ragazzi, “La favola dello sport”. Con Pietro anche Gabriella Dorio e Roberto Boninsegna, Gianni Bugno e Sandro Boni, Roberto Di Donna e Marco Meoni. E poi, tra i mantovani, Fausto De Stefani e Giovanni Lorenzi, Diego Marani e Massimiliano Saccani. Una formula coinvolgente: i campioni a raccontare le proprie esperienze, gli scrittori a catturare con i ragazzi gli elementi fiabeschi, i pittori a dipingerli. Ne è nato un libro, “La Favola dello Sport”, unico nel suo genere, quasi un lascito spirituale degli atleti alle nuove generazioni. E’ toccato a me e a Roberto Borroni il compito di coordinare gli interventi coinvolgendo per i testi anche Antonio Voceri, Matteo Bernardelli e Alberto Sogliani e per le illustrazioni Edoardo Bassoli, Patrizia Minelli, Sandro Negri e Roberto Pedrazzoli, Ed è stato in questa fase, in questo far riemergere dall’onda della memoria storie che soltanto in apparenza sembravano prive di pathos, è stato in questa fase che ho conosciuto di Pietro Mennea l’altra faccia della luna, quella più nascosta, quella mai neppure supposta da noi profani ammaliati dalle immagini della corsa.
Dove è cominciata, gli chiesero, la favola di Mennea? “E’ cominciata su un rettilineo a perdita d’occhio mai imbrigliato dalle corsie. Un rettilineo da percorrere di corsa oppure al passo, indifferentemente, senza che un traguardo comparisse mai alla vista”. Nessun traguardo? chiesero i ragazzi. “Non esistono traguardi. Ogni traguardo non è altro che un punto di partenza”.

Quando Pietro ci ha lasciato, allungando troppo in fretta la falcata, il finale della favola era ancora da scrivere. L’immagine di quel punto di partenza indefinito, con il finale che correva in libertà verso l’ignoto, è rimasta a lungo sospesa a metà del volo, veloce al decollo ma poi presa nel giro matto delle correnti. Finché a indicare non uno ma cento, mille finali, in mille direzioni diverse -senza regole e senza preavviso, con trame così straordinariamente innaturali da essere sempre sul punto di reinventarsi- a indicare il finale della favola, dicevo, è intervenuta la fantasia dei ragazzi. Da parte loro c’è stata una scelta di libertà espressiva infinita, la stessa libertà che Pietro ha cercato con tenerezza e con rabbia in ogni attimo della sua esistenza, nella corsa prima e poi nelle vicende di vita, e che ha trovato casa in quella sua poesia che somiglia ora a un accorato passaggio di testimone: “Quando ho provato a volare/l’ho fatto per raggiungerti/ quando ho provato a fermarmi/sei stata la mia stella/ quando diventerò vecchio/ti chiedo solo/di non abbandonarmi/ quando non ci sarò più/sarei sempre con me”.
Il concetto di libertà, così caro a Pietro, è stato al centro di tutti gli incontri con i ragazzi. Ma cos’è la libertà? gli è stato chiesto. La risposta ha colto un po’ tutti di sorpresa, non so fino a che punto a ispirarla sia stata la presa d’atto di una certa filosofia Zen: “La libertà -disse Pietro- è avere la possibilità di inseguire. Nella mia vita ho inseguito tutti e tutto. Ho inseguito i miei avversari per superarli, ma ho inseguito soprattutto me stesso, cercando di realizzare i sogni che avevo da ragazzo, quei sogni custoditi così a lungo nella mente e nel cuore”.
Da ragazzo Pietro amava leggere e amava scrivere, amava le lettere. Fosse dipeso da lui si sarebbe iscritto al Liceo Classico ma a Barletta c’era solo Ragioneria e quel diploma non era certo bastato a motivarlo. E così, già durante la carriera, sono arrivate le lauree in Scienze motorie e in giurisprudenza. A fine carriera quella in Scienze politiche. E l’amore per le lettere? Quel sogno impossibile da inseguire, appunto, e da realizzare? La laurea in lettere, la quarta della serie, quella sarebbe arrivata a 49 anni, e avrebbe coronato l’inseguimento più carico di motivazioni, e più ricco di pathos, di tutta la sua vita.
Chiesero a Pietro come mai non c’era più stato, dopo di lui, un altro Mennea. Lui rispose che di Mennea ce n’erano stati e ce ne saranno tanti. Anche di più veloci. Un solo problema: non l’avevano mai saputo, e non lo avrebbero saputo mai. Il loro percorso da un cartone animato a una consolle dei videogiochi non poteva intercettare le abilità motorie, e anche quando un insegnante se ne fosse accorto, gran parte del potenziale di quei ragazzi sarebbe già andato perduto, fatto a brandelli per il non uso. E poi c’era anche un altro tipo di problema: la sparizione dei prati di periferia dove i ragazzi potevano correre e giocare in libertà. Oggi non si gioca e non si corre più neppure nei cortili di casa, per non recare disturbo alla quiete dei condomini. Viene a mancare anche il piacere del confronto con gli amici, nessuno sa più chi corre più forte, chi salta più in alto, chi lancia più in là. Per non parlare di quel meccanismo becero che vorrebbe imporre ai bambini di giocare a calcio senza vinti né vincitori, di azzerare i gol e anche le classifiche, di correre gli uni accanto agli altri in modo che l’ultimo sia anche il primo E viceversa. Senza mortificazione. Ma anche senza il lampo, o il brillio, che è il regalo di ogni piccola sfida.
Molto dipende anche dagli insegnanti, pochi dei quali accettano di mettere a disposizione il proprio tempo dopo l’orario di lezione. “Non è vero -diceva Pietro- che le motivazioni, i ragazzi, devono trovarsele da soli: serve invece qualcuno che le intuisca e che le inneschi”. E’ il solito vecchio discorso: i ragazzi non sono contenitori da riempire di nozioni, o di consigli, ma fuochi da accendere.
E’ stato questo, mi è venuto da chiedergli, il lavoro che Carlo Vittori ha compiuto con te? Carlo Vittori è stato l’allenatore storico di Mennea, formava con lui una coppia che appariva inscindibile, la mente e il braccio. Ma non era così. L’ispirazione e la motivazione sono concetti in evoluzione. “Durante la mia carriera sportiva -rispose Pietro- Vittori non ha mai cercato di motivarmi. Forse perché io stesso ero ben più motivato di lui. Non ha mai cercato di entrare nella mia vita, di conoscermi. Il vero allenatore di Mennea era Pietro Mennea. Fosse dipeso da me mi sarei allenato non cinque ma sette ore al giorno. E non avrei sostenuto, prima delle Olimpiadi di Mosca, quel lavoro con i bilancieri che ha rischiato di spezzarmi la schiena”.
Si parlava di cose come queste con Pietro e con i ragazzi. Pietro che ha continuato a inseguire, raccontava, un compagno di scuola più veloce di lui, un certo Salvatore Pallamolla, finché non è riuscito a batterlo. Ma la folgorazione, il flash che gli ha acceso la mente, risale all’estate del 1968, Olimpiadi messicane, quelle che videro Tommie “Jet” Smith e gli atleti neri d’America esibire sul podio il pugno guantato del Black Power. “Vedere Tommie e sognare di imitarlo è stato simultaneo. Non sapevo ancora che l’avrei inseguito così a lungo, anche come modello di vita, e che su quella stessa pista di Città del Messico avrei migliorato quel record del mondo che mi sembrava imbattibile. Ma la cosa più bella è stata scoprire che dietro un atleta fantastico c’era anche un uomo di grande umanità”.
Dopo il record del mondo, quel 19”72 che ha resistito imbattuto per 17 anni fino all’entrata in scena di Michael Johnson, che vinse ad Atlanta i 200 e i 400 metri, c’era ancora un traguardo che Pietro inseguiva tenacemente e che avrebbe rappresentato il top della carriera: la vittoria olimpica. A Mosca, nel 1980, aveva già 28 anni, un’età avanzata, allora, per un velocista. Non si era presentato al meglio della forma, i problemi con Vittori avevano lasciato qualche scoria. Nei 100 metri era stato eliminato addirittura in semifinale, nei 200 metri avrebbe incontrato Alan Wells, lo scozzese pigliatutto, già vincitore dei 100 metri, fisicamente un armadio, rispetto a Pietro. Partita chiusa? I tecnici, anche quelli italiani, la pensavano così.
Accadde invece qualcosa di imprevisto. Prima della finale Pietro incontrò Valerj Borzov, uno dei suoi idoli, Borzov che l’aveva battuto otto anni prima alle Olimpiadi di Monaco. Borzov lo guardò negli occhi e vide uno sguardo spento, privo della fierezza di un tempo. “Devi guardarti dentro -gli disse-: non pensare a quello che hai fatto ma a ciò che puoi tirare fuori adesso. Wells è davvero in forma ma io non ho mai visto nel finale di gara una progressione come la tua. Devi tornare a mordere la pista”.

Scoccò all’improvviso la scintilla, e la gara che gli regalò la medaglia d’oro sulla pista dello stadio Lenin a Mosca, fu una liberazione, l’uscita dal tunnel. “Uno sprinter -disse Pietro- non può mai portarsi in pista pensieri pesanti. Il bagaglio a mano previsto nel cervello prima del decollo prevede al massimo di ricordarsi del sogno e di un po’ di quella rabbia che fa parte del gioco”.
Un gioco, quello della corsa, che Pietro ha interrotto per tre lunghi anni per inseguire altri sogni, lontano dalle piste, e che lo ha catturato di nuovo alla vigilia del primo Mondiale della storia, Helsinki 1983. Anche qui due medaglie, di bronzo nei 200 e d’argento nella staffetta. E poi ancora due Olimpiadi, a Los Angeles 1984 e a Seul 1988, e altre lauree, e altri traguardi-punti di partenza da superare: il Parlamento europeo, l’attività di avvocato di grido, e i 23 libri scritti di getto per raccontare e per raccontarsi. Gli ultimi due, usciti nel 2012, un anno prima della sua scomparsa, hanno titoli esaustivi: “Inseguendo Bolt” e “La corsa non finisce mai”. Appunto.