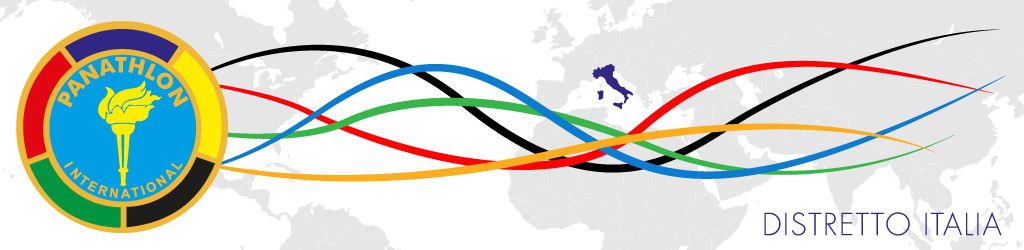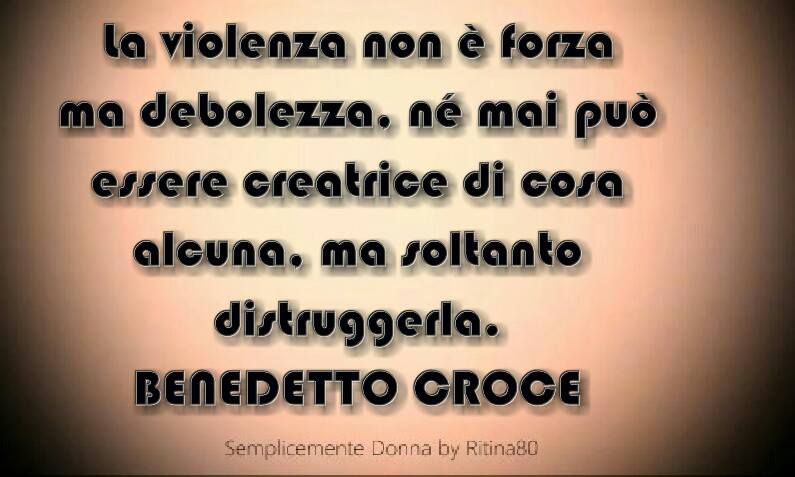Ad un’Italia che cerca di guardare al futuro se ne contrappone un’altra volta al passato. In questi due mondi un ruolo importante lo gioca la donna, solamente che in un uno, quello che guarda al futuro, essa può rivestire ruoli di prima grandezza per le capacità riconosciutele, senza essere imposta dalla demagogia delle quote rosa. Nel secondo, quello del mondo a valenza maschilista, invece le è imposto il Burqa, ovviamente è una provocazione, affinché la donna non scopra la propria intelligenza e rimanga così oggetto o persona di serie B. Dunque ad una società evoluta se ne oppone un’altra l’esatto suo contrario. Ed è proprio in quest’ultima che ricade il caso della pallavolista licenziata perché incinta, tema trattato qui sotto dalla nostra Alessandra Rutili, ed in altra parte di Planet da Valerio Rosa. Un fatto accaduto realmente nell’Italia dello sport. Massimo Rosa/Direttore

Qui Verona – Alessandra Rutili – Area5
Sono stati in molti a gridare allo scandalo dopo aver letto la notizia dell’atleta friulana chiamata a risarcire la propria società dopo aver interrotto il contratto per una gravidanza. Pura ipocrisia, ma almeno la denuncia della pallavolista Lugli ha sollevato uno dei tanti problemi legati alle donne.
I fatti sono abbastanza chiari; una ragazza rimane incinta, lo comunica alla società sportiva con la quale ha un contratto, smette di giocare, non riceve l’ultima mensilità e a distanza di 2 anni, le viene chiesto di pagare dei soldi per i mancati introiti causati dalla sua assenza. Per la cronaca la gravidanza non andrà bene.
Per capire meglio bisogna dire che in Italia le atlete donne, in quanto non riconosciute come professioniste, smettono di giocare e di avere un rapporto “lavorativo” con la società nel momento in cui comunicano di essere incinte. Per loro non vi è nessuna garanzia, nessun assegno di maternità, nulla. Sei incinta, non puoi giocare, non ti pago. Già questo dovrebbe indignarci perché si parla di equiparare gli stipendi, colmare i gap di genere e poi non vengono estesi i diritti per i quali tante donne e tanti uomini si sono battuti.
Come se non bastasse si imputa all’atleta una colpa, quella di aver procurato un danno economico alla società sportiva, nel momento stesso in cui ha deciso o ha scoperto di essere incinta. Ed è questo il nocciolo della questione. Nello sport come nel 99% dei settori lavorativi diventare madre rappresenta un ostacolo.
In primis la paura di comunicarlo perché si teme di arrecare disagi all’azienda e ai colleghi, poi la certezza che tornate al lavoro le mansioni potrebbero cambiare o addirittura si potrebbe perdere quel lavoro. La cruda verità è che la nascita di un figlio condiziona la vita e le scelte di una donna alla quale, non si capisce perché, viene chiesto di gestire la nuova situazione. Conosco moltissime donne che hanno inseguito carriere posticipando la scelta di diventare madri per timore di perdere il treno giusto. Amiche che hanno dovuto ridurre l’orario di lavoro per gestire la famiglia e per questo sostituite nel ruolo che avevano prima. Non mi sono stupita quando ho letto la notizia. Io stessa ho dovuto scegliere. Ho scelto di diventare madre, rinunciando al mio lavoro. Lo sappiamo tutti che le cose vanno così nel nostro Paese.
Spero possa servire la denuncia della Lugli per riformare le leggi relative al contratto di lavoro nello sport e per portare al centro del dibattito sociale un problema che riguarda tutto il Paese.
Se sempre meno donne scelgono di diventare madri ci sarà un perché? perché sanno che si troverebbero davanti ad una scelta: famiglia o lavoro?. E dopo aver dedicato la propria gioventù allo studio qualcuna può anche non voler rinunciare ai propri sogni. Non credo che le cose cambieranno, nei contratti sportivi magari aggiungeranno qualche clausola, ma il pensiero di molti rimarrà lo stesso: farai figli quando non giocherai più.