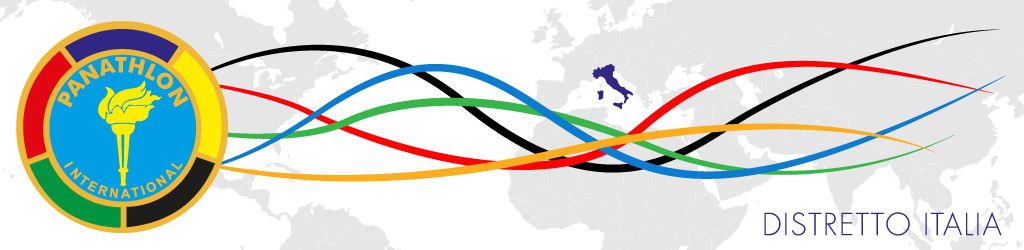-Di Filippo Grassia–
Gli piaceva cantare all’infinito e andare in bici nei mesi buoni con un cappello di paglia portato a mo’ di Borsalino gli piaceva visitare con la moglie Federica paesi all’estremo degli itinerari turistici e stare con gli amici che di calcio parlavano ma che del calcio non facevano parte. E poi e sempre, Paolo Rossi sorrideva alle persone care, agli amici, alla vita. Con le bambine, Maria Vittoria di 11 anni e Sofia Elena di 8, era tenerissimo, s’illuminavano i suoi occhi nei momenti in cui le coccolava. Non riesco a parlare o scrivere di lui come di Pablito e basta, del calciatore che ci ha fatto vincere il titolo iridato di Spagna 1982. Dietro le vesti del goleador intelligente e spietato, c’era un uomo straordinario, di una semplicità infinita a dispetto d’una immensa popolarità. Uno di noi, sicuramente migliore. All’inizio di questo millennio un sondaggio certificò che lui, e non altri, era l’italiano più conosciuto nei cinque continenti. “Paolo Rossi”, un brand.
L’ultimo ricordo gioioso fa data all’agosto di un anno fa quando ci allietò con la sua voce intensa nella consueta cena estiva organizzata dall’amico Balloni a Marina di Massa. Poi il viaggio alle Maldive con Federica. E i primi segnali del male che all’inizio non sembrava nemico. Infine, i mesi terribili e angosciosi con la fine nelle braccia della sua donna cui, qualche ora prima, aveva scritto parole dolcissime. Sapeva di essere vittima d’un male incurabile, eppure sperava di farcela, di continuare a stare con le ragazzine e Alessandro, il figlio avuto dal primo matrimonio. Questa volta il pallone, non è retorica, ha sfiorato il palo e lemme lemme è uscito sul fondo. Ciao Paolo.
Per una serie di inesplorabili coincidenze fui spettatore di tanti suoi momenti, belli e brutti. A Perugia lo andavo a trovare nello spogliatoio dello stadio Curi, dove il massaggiatore ricopriva di ghiaccio quelle ginocchia fragili come cristalli di Murano. Di menischi neanche l’ombra. Riascolto con tristezza cosa disse all’indomani della squalifica di due anni per aver accettato con eccessiva educazione l’invito di Della Martira, suo compagno di squadra, a parlare con i due faccendieri dell’epoca, Trinca e Cruciani. “Era la vigilia di Avellino-Perugia. Mi parlavano di pareggio. Ma io stetti ad ascoltare il minimo necessario prima di tornare a giocare a tombola. Mai accettai la combine, mai accettato una combine. In campo feci il mio e segnai due gol, belli e difficili, andate a rivederli”. Per quel poco fu messo alla sbarra. Durissimo fu il primo anno. Poi Boniperti, che di calcio se ne intende, lo portò alla Juve: “Allenati forte, ti rialzerai”. Nel frattempo, l’Italia, orfana di lui, non era riuscita a vincere l’Europeo disputato in casa.
Ero allo stadio Friuli nel maggio 1982 quando tornò in campo realizzando pure un gol. Mi trovai con Enzo Bearzot e Giovanni Arpino nell’appartamento di quest’ultimo, nei pressi di corso Sempione, a Milano, quando il ct ci disse che avrebbe puntato su Paolo Rossi al Mondiale. E per questo fu dileggiato anche da giornalisti di vaglia. Ero al Bernabeu di Madrid ad applaudire il suo primo gol alla Germania nella finale mondiale. Ed ero a San Siro quando firmò una doppietta all’Inter con la maglia del Milan, la sua ultima impresa. A distanza di qualche mese mi disse che non poteva più essere Pablito con quelle ginocchia scricchiolanti. Già Pablito. Il nomignolo inventato dal collega Giorgio Lago dopo lo strepitoso debutto nel Mondiale d’Argentina del 1978. Al funerale di Bearzot si comportò come un figlio che deve tanto al padre.
Oggi che non c’è più, parliamo di lui, delle sue vittorie, dei suoi gol, del Pallone d’Oro, del suo modo di leggere il gioco e di sapere, prima di chiunque altro, dove sarebbe finito il pallone. Affranti e tristi. Ci dovremmo però ricordare anche di chi è rimasto nel dolore della sua assenza, di Federica, Maria Vittoria, Sofia Elena e Alessandro. In particolare, di quelle ragazzine che non potranno più giocare sulle gambe di papà.