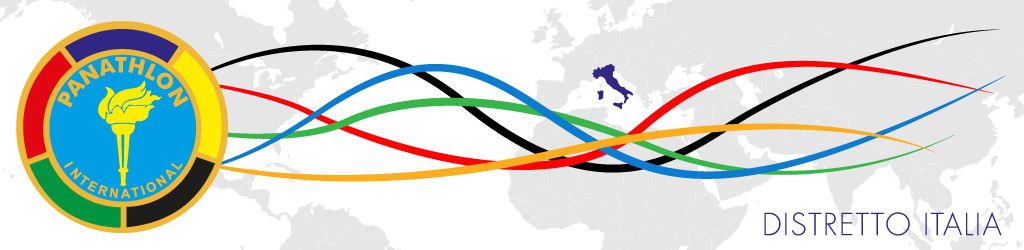-di Adalberto Scemma–
Non basta certo questa paginata. Ma neppure un libro intero basterebbe a raccontare la leggenda di «Carburo». Prima di tutto perché le parole, inchiodate a immagini vibratili, uscirebbero subito dai margini chiedendo spazio. E poi perché l’ultima pagina non verrebbe mai scritta. Non è contemplata, per le leggende, la parola fine.
Dovrei affidarmi alla retorica per raccontare le imprese di William Negri a generazioni di lettori cui l’anagrafe ha negato il piacere della testimonianza diretta. Ma avrebbe senso? Correrei il rischio -dico della schiera non più foltissima dei miei coetanei- di sovrapporre immagini ormai banalizzate (l’eroe del Prater, il Piccolo Brasile, lo scudetto del Bologna) a quelle, tuttora nitidissime, incapsulate gelosamente nell’archivio della memoria.
Nel mio archivio personale l’immagine di «Carburo» è legata in maniera indissolubile a un calcio fuori copione se rapportato ai canoni odierni, un calcio di spiritata anarchia e di amicizie cucite a doppio filo. L’anno è il 1955, il secondo della Quarta Serie biancorossa, il primo dell’era Fabbri. Da Governolo «Carburo» arrivava al Martelli in motorino, un Guazzoni 98 pilotato da Guido Furini. Un miracolo di equilibrio dinamico: Guido avanzava il baricentro fino a striminzirsi con la metà delle chiappe appoggiate al serbatoio mentre lui, «Carburo», artigliava con presa ferrea l’altra metà con le sue, di chiappe, che sporgevano per tre quarti fuori dal sellino. Ma c’era spazio, irrisolto mistero gaudioso, persino per due bisacce con gli scarpini e la maglietta di ricambio. E quando Guido marcava visita, no problem: «Carburo» faceva avantindrè da Governolo in bicicletta.
Erano anni così, privi d’angosce e ricchi di sogni. Lo stipendio? Cinquemila lire al mese, che con i premi diventavano sette, otto, mai dieci. Ma a vent’anni, con quei soldi, si faceva festa. Lo racconta con gli occhi lucidi Paciana», popolare scutmâj di Angelo Passerini. Perché la festa era tutta in uno spuntino al sacco, a fine allenamento: «Carburo» portava le mele, Mario Veneri la mortadella e «Paciana», fornaio, ci metteva il pane. Di più non serviva, l’allegria era gratis. E quando qualcuno di loro compiva gli anni, «Tabàr» Longhi, «Cina» Salardi o Massimo Paccini, tutti a fiondarsi da Tosi, alla Casa dei Dolci per una sfida a sensazione: il record è di «Carburo», dodici paste l’una dopo l’altra, alè, in catena di montaggio.
Non sarebbe cambiato, «Carburo», neppure negli anni successivi, quelli del successo. Anzi: non sarebbe cambiato mai. Spirito libero, considerava il calcio niente più che una suggestione. Fosse dipeso da lui, del resto, non avrebbe giocato a calcio ma a pallavolo. Il Mantova (1957-’58), lo aveva spedito in prestito militare al Bagheria, la squadra dei Cantieri Navali di Palermo. All’epoca, per dire, «Carburo» saltava più di 7 metri in lungo e 1,80 in alto all’italiana, valicando l’asticella dritto per dritto. Un atleta naturale. Di un eclettismo solare. Da ragazzo, ai tempi della Libertas, era salito sul podio anche nelle prove multiple con un altro biancorosso d’antàn, Alfonso Bosellini. A Bagheria invece vestiva soprattutto, da pallavolista, la maglia della Nazionale militare. A calcio, sui campetti diserbati del contado siciliano, giocava quando gli girava giusta, nei ritagli d’umore.
Qualche anno più tardi, nella prima stagione di B del Mantova di Fabbri (campionato 1959-’60), «Carburo» faceva anche di peggio, o di meglio, a seconda della valenza che si intende dare alle sue funamboliche sortite: la domenica mattina giocava a pallavolo con l’Ardens di Governolo nella palestra di via Frattini, accanto ai maestri giaguari del volley di allora, Idreno Bianco, Angelino Gozzi, Gianni Togliani, e poi Lorenzini, Gueresi, Tuto Bambini; nel pomeriggio scendeva regolarmente in campo con il Mantova al Martelli. Fabbri gli dava il via libera senza chiedergli il perché e il percome. Era convinto che andasse a messa in S.Egidio con Longhi e Paccini, che a messa ci andavano davvero !
Negli anni di Bologna era la dannazione dei giornalisti. Non rilasciava interviste. Non amava, soprattutto, le domande banali. Alla vigilia della partita-spareggio contro l’Inter, mentre sgambava a bordo campo, era stato affiancato da un trotterellante Pier Paolo Patelli, cronista allora del Resto del Carlino. «Ciao William che partita ti aspetti?» Silenzio. «Come ti senti, sei fiducioso?». Ancora silenzio. «Chi temi di più, Mazzola o Corso?» Risposta secca: «Questo è un problema mio». «Ma insomma, dimmi qualcosa, io devo scrivere l’articolo». «Questo non è un problema mio, è un problema tuo». Fine della storia.
***
Non c’è mai la parola fine, invece, alla storia di chi fa la guardia ai pali di una porta. Ciò che rimane di un portiere, anche ripensando a «Carburo», è sempre un quid di ineffabile, un’idea musicale, un alone di misteriosa magia. In ogni portiere -qualcuno ha scritto- si nasconde un poeta. Il fatto che sappia o meno scrivere versi è incidentale: si può essere poeti a prescindere, basta un filo d’anarchia e si impara a guardare oltre, come ci si aspetta che faccia un portiere ma anche un visionario, e quindi un poeta. Tale era «Carburo», con quel suo modo personale e a tratti indecifrabile di rapportarsi alla vita. Chi gioca in porta, del resto, è diverso in tutto e per tutto da chi gioca fuori. Gli sono permesse cose che agli altri sono vietate: usare le mani, ignorare gli schemi, padroneggiare uno spicchio d’area dove nessuno può caricarlo impunemente. Di suo ci mette la vocazione, una forza d’animo che può sfociare a tratti nel misticismo. Pensiamo allo spirito di sacrificio, alla disponibilità a rischiare, che è poi un obbligo morale. Il portiere può essere un giustiziere o un vendicatore ma è privo di ambiguità: essendo l’ultimo baluardo, è in qualche modo un eroe designato. «Ho capito subito che il pallone non arriva mai dove te l’aspetti. Mi è servito più tardi nella vita, dove non ci si può fidare di nessuno». A scriverlo non è un portiere qualsiasi, e non è neppure uno scrittore qualsiasi: è Albert Camus, che ha difeso per anni la porta dell’Algeria («Se non mi fossi ammalato di tubercolosi -arrivò a dire- forse non avrei mai fatto lo scrittore-filosofo e avrei continuato a giocare»).
Non è privo di senso, con tali presupposti, che molti portieri-poeti (o poeti-portieri, non c’è differenza) abbiano deciso di mettersi a scrivere soltanto a fine carriera, quando la libertà espressiva si è trasferita dai pali di una porta ai tasti di un computer. Penso a Giuliano Terraneo, una bella carriera tra Torino, Milan e Lazio, poeta di versi lunari, ma anche a Sepp Maier, a Toni Schumacher, autori di libri di successo, e soprattutto a Uli Stein e al suo incipit di «Halbzeit» (Un bilancio senza difesa), bestseller uscito nel 1993 e ripubblicato di recente: «Sono un combattente solitario. Dopo di me non c’è più nulla. Sono l’ultimo uomo, ne sono consapevole, nessuno può far nulla per me».
D’obbligo la verifica: «Il portiere caduto alla difesa/ultima vana,contro terra cela/la faccia, a non veder l’amara luce/Il compagno in ginocchio che l’induce, /con parole e con mano, a rilevarsi, /scopre pieni di lacrime i suoi occhi».È l’incipit della prima tra le cinque poesie dedicate da Umberto Saba al gioco del calcio. Un trasporto umorale curioso, perché a far vibrare le corde del sentimento non è il guizzo elettrico di un centrattacco ma il reclinare supino di un portiere.
A differenza di altri «viaggiatori del sogno» (Camus, Nabokov, Evtušenko, Pratolini, tutti portieri di provate capacità, di Camus s’è detto, addirittura nazionale d’Algeria) Umberto Saba non ha mai giocato in porta. E neanche fuori. Il calcio l’ha sempre guardato di sghimbescio, passo dopo passo a Valmaura, quando le maglie rosse di Colaussi, Rocco, Pasinati infiammavano Trieste. Curioso-non tifoso d’Alabarda, Saba s’immergeva in quel calcio di frontiera con emozione vigile. Sapeva coglierne le sfumature, gli spunti emotivi, i dettagli sonori. Come in gennaio -era un giorno di rigido sole, campionato 1933-34- quando il flash della mente scattò per Gino Ambrosio, il portiere «caduto alla difesa» in un Triestina-Padova che l’Alabarda vinse poi, in affannoso concitato recupero, per 2-1.
Era un calcio naif che esaltava gli aedi giuliani, Nino Nutrizio tra questi, a sua volta portiere delle giovanili a Trieste, ma che ben poco concedeva all’analisi tecnica. In quel Padova sconfitto a Valmaura giocavano Aldo Olivieri e Alfredo Foni, campioni del mondo quattro anni più tardi con i triestini Gino Colaussi e Piero Pasinati ma nessuno di loro seppe incantare lo sguardo di Saba quanto il gesto sconsolato di Ambrosio. E il ruolo del portiere, da quel momento, diventò per lui fonte inesausta d’ispirazione quando lo stesso sguardo si fermò in sospensione per osservare Giacomo Blason, il portiere della Triestina, dall’altro lato del campo partecipe non silente di quello stesso gol: «Presso la rete inviolata il portiere/– l’altro – è rimasto. Ma non la sua anima, /con la persona vi è rimasta sola. /La sua gioia si fa una capriola, /si fa baci che manda di lontano. /Della festa – egli dice – anch’io son parte».
Una festa, per traslazione temporale, di cui chiamo a far parte anche William Negri. E penso alla poesia in musica su «Carburo» e sugli antichi eroi dello scudetto del Bologna che non fu mai scritta. Lucio Dalla e Roberto Roversi si erano lasciati strappare una mezza promessa alla vigilia del trentennale, 1994, ma era un’annata grama per il Bologna, precipitato in serie C, e non ne trassero ispirazione. Così «Carburo» ci saluterà ancora una volta in silenzio, a modo suo. Anche se la musica, vedrete, uscirà comunque nota dopo nota, rapsodica, dalla verde fessura d’un campo di calcio.
Le foto ed i video presenti su PANATHLON PLANET sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà segnalarlo alla Segreteria di redazione: segreteria.redazione@panathlondistrettoitalia.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.