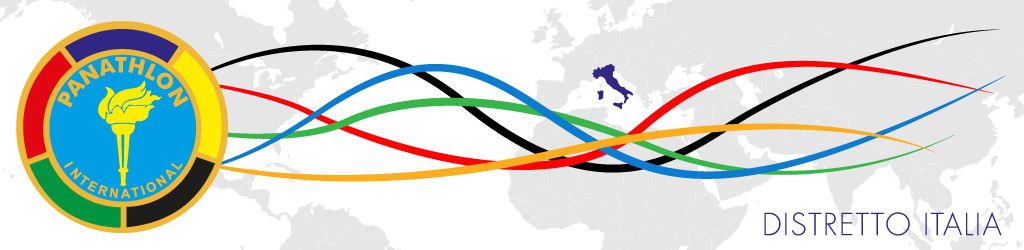–di Francesca Tibaldi-
Dare una definizione che sia molto vicina al significato intrinseco di Empowerment così come riportato dal vocabolario della lingua inglese e tradurlo letteralmente in italiano non è cosa semplice. Non tanto per una traduzione simultanea delle parole, quanto per la molteplicità degli ambiti a cui è applicato che ne modificano l’accezione. La stessa parola inglese, risulta dalla composizione di Em – power – ment; il prefisso “Em-“ solitamente si usa per prevedere un “andare verso”, “-power-” letteralmente significa potere, ma qui nella sua accezione positiva e costruttiva come dare e avere il potere per la costruzione di un risultato attraverso un processo, come ci marca il suffisso “-ment” usato solitamente per delle parole inglesi che adducono ad una funzione di fine.
Concentrandosi quindi sul concetto di “accrescimento personale” ne deriva un’applicazione e un modus operandi tra i più svariati, così come pure gli ambiti di pratica possono essere individuali o di gruppo o di funzione ma sempre orientati ad un miglioramento personale o di sistema per esempio aziendale o di comunità. Risulta quindi più corretto parlare di Empowerment e riferirsi ad un divenire, trascendendo da un significato fisso e stabile ma alludendo a un qualcosa che avverrà attraverso dei passaggi: Empowerment è processo ed anche risultato. Ad un livello individuale è la possibilità delle persone di sentirsi responsabili, protagoniste della propria vita; ad un livello organizzativo è la possibilità per un gruppo di essere più efficaci nel funzionamento e nelle sfide innovative. In entrambi i casi comunque si parte da una situazione attuale per migliorarla, potenziarla, col presupposto che tutti abbiano delle risorse che possono sviluppare.
Empowerment significa aumento di energia, di vitalità, di partecipazione, di
responsabilità, valorizzazione delle risorse umane e utilizzo ottimale delle
migliori risorse e del potenziale delle persone, dunque sviluppo di una cultura orientata al positivo. Nel suo contrario, un soggetto debole, dipendente, passivo, pessimista, è un soggetto disempowered al quale va ridato potere, un soggetto che deve essere rafforzato, che va aiutato nell’attivazione e a volte anche nella scoperta stessa delle sue risorse.
Come l’empowerment è entrato nelle categorie dei disabili e di come, all’atto pratico, lo sport fa superare la disabilità? Questo è possibile quando anche e soprattutto si capisce profondamente che un atleta disabile è un atleta. Punto.
Vi è una tendenza nel mondo occidentale a promuovere l’integrazione delle persone con disabilità fisica, anche nello sport. Lo sport, dunque, è stato considerato un insegnamento di valori positivi, come la costruzione di un carattere e di un fisico più forte e più maturo.
L’empowerment, in questo caso è visto come un processo progressivo di adattamento, che non implica necessariamente una situazione iniziale di disagio o svantaggio. In altri termini, l’empowerment aumenta la qualità organizzativa nella misura in cui aumenta l’interazione sociale, intesa come il processo di apprendimento e di negoziazione di significati che intercorre tra gli attori sociali, tramite le loro reciproche azioni. In particolare, il Comitato Paralimpico Internazionale dello Sport, ha definito l’empowerment come un tema di ricerca prioritario all’interno del settore della disabilità sportiva: il processo attraverso il quale gli individui sviluppano le competenze e le capacità la loro situazione di vita. Il disabile convive con pesanti modificazioni della propriocezione, della esterocezione, delle sensazioni relative al dolore/piacere; alcuni piaceri gli sono preclusi, alcuni dolori diventano abituali o comunque più frequenti della norma e alcune sensazioni muscolari sono assenti dalla nascita o sono improvvisamente sparite. Il quadro affettivo legato alla propria immagine psichica risente sia dei connotati negativi risultanti dalla propria figura riflessa nello specchio, che del giudizio degli altri. Nell’affrontare un contesto sociale c’è dunque una inibizione determinata dalla coscienza di disporre di un corpo imperfetto. Queste sono le premesse fondamentali dinnanzi alle quali si trovano sia il disabile che vuole intraprendere l’attività sportiva, sia il tecnico che insieme a lui deve affrontare un percorso complesso e a volte difficile. Si fonda tutto sull’integrazione di questi atleti e come ciò potrebbe modificare il proprio livello di empowerment. Si tratta, dunque, di capire se gli atleti con disabilità perdono il loro “potere” oppure riescono, attraverso l’integrazione, a diventare atleti qualificati.
Un aspetto importante consiste nel saper fronteggiare sia gli aspetti tecnici della disciplina, sia le dinamiche che si sviluppano nella relazione. In base a quanto espresso finora si può comprendere come il disabile rappresenti una sfida ancor più ardua per il tecnico che si trova a lavorare con lui. Infatti, nel caso della disabilità fisica si assiste ad una compromissione del piano corporeo/motorio e, conseguentemente, di quello emotivo, invece nel caso della disabilità mentale la compromissione investe anche il piano cognitivo. Ciò comporta una grande difficoltà, a seconda del grado di disabilità, rispetto alla capacità di percepire e pensare di se stessi e degli altri; elaborare i propri ed altrui stati emotivi; saper contenere i propri stati emotivi; comunicare con il mondo esterno; essere attenti; saper apprendere e memorizzare; essere motivati. Per un disabile la pratica regolare dell’attività sportiva riveste i seguenti vantaggi:
- rispetto ad un piano cognitivo migliora la conoscenza del proprio corpo, dello spazio, del tempo e della velocità;
- rispetto ad un piano fisico, incrementa la forza muscolare, la capacità di equilibrio, la cinestesia e la coordinazione motoria, grazie alle ripetizioni consapevoli e finalizzate degli atti motori;
- rispetto ad un piano sportivo, acquisisce le conoscenze tecniche delle varie discipline sportive.
La pratica sportiva produce uno stato di soddisfazione generale, favorisce la disciplina e l’allenamento che, di conseguenza, portano al contenimento degli stati emotivi incrementando la capacità di autocontrollo, in modo da avere la possibilità di aumentare la propria autonomia. Nella metodologia d’insegnamento proposta, il tecnico deve tener conto delle tappe dello sviluppo psicofisico dell’allievo, in quanto la sua capacità di ricezione ed assimilazione di contenuti e proposte pratiche è strettamente correlata alla sua maturazione psicofisica. Secondo il principio dell’individualizzazione, si considerano le differenze individuali nei ritmi cinetici, nell’efficienza e nell’efficacia causate dal deficit. Il tecnico deve saper apprendere e riconoscere questi diversi aspetti, poiché in base a questi sarà possibile una buona programmazione didattica. La funzione socioeducativa dell’attività motoria aiuta l’individuo a sviluppare al massimo le sue potenzialità, evidenziando ciò che egli è già in grado di fare. L’individuo disabile, dunque, prima conoscerà se stesso, il suo corpo, in seguito sperimenterà la motricità altrui, imparando ad osservarla, interpretarla e riconoscendone il suo valore espressivo. Lo sport capovolge la situazione in cui si trova il disabile, egli infatti si trova ad aumentare le proprie attività, ampliando il proprio volume di azione e allargando gli orizzonti fisici. L’allenamento rappresenta la chiave del successo e per la sua programmazione, la relazione tra l’allenatore e l’atleta gioca un ruolo decisivo. Concludendo, si può constatare come il disabile, spesso per i suoi deficit cognitivi, presenti una difficoltà nell’elaborazione mentale dell’azione da compiere che a volte risulta rigida e poco adattiva. Questo significa che l’atleta disabile con lo sport è in grado di padroneggiare gli ambiti della vita, a volte ben più di un normo dotato. La percezione dell’handicap anche da parte del contesto sociale si riduce fino quasi ad esaurirsi in situazioni di elevato risultato competitivo. Mi piace citare spesso che il triathlon è rimasto uno sport semi sconosciuto per 30 anni in Italia, fino a quando Alex Zanardi nel 2015 ha occupato un’intera pagina della gazzetta dello sport per la sua impresa di aver concluso l’ironman delle Hawaii in poco più di 9 ore.
Giovanni Sasso, che si fa chiamare da tutti Gianni, classe 1969, è stato un atleta azzurro di Paratriathlon nella categoria PT2 con la cui nazionale ha partecipato alle Para Olimpiadi di Rio nel 2016.
Appassionato di calcio sin da giovane, a 16 anni, mentre è in vespa con un amico, una macchina invade la corsia dei due ragazzi travolgendoli in pieno. Nonostante l’amputazione riportata a seguito dell’incidente, “Gianni” non si è arreso: ha ripreso a giocare a pallone fino ad arrivare a giocare i Mondiali con la Nazionale amputati in Messico, capitanata da Francesco Messori.
Avvicinatosi al Paratriathlon nel 2014, Giovanni Sasso ha alle proprie spalle un passato di vero atleta: ex dirigente di una squadra di calcio a 5 semiprofessionista e capocannoniere della Nazionale di Calcio Amputati della stagione 2014-2015, nel 2012 realizza il record del mondo della maratona con stampelle di Amsterdam con un tempo di 4 ore e 28 minuti.
Ho avuto il piacere di conoscere Gianni due anni fa a Verona in occasione di un raduno della nazionale italiana di Paratriathlon, quando facevo la guida per l’atleta non vedente Anna Barbaro. Quello che colpisce di Gianni sono il suo sorriso, gli occhi e i capelli corvino, quel fascino penetrante di uomo del sud. L’intervista che riporto è stata concessa in occasione della mia tesi di laurea nella materia di Psicologia di comunità dal titolo “L’empowerment nello sport e disabilità”.
F.T.: Il tuo debutto nel triathlon ha suscitato molta curiosità. Come hai superato le difficoltà legate alla preparazione di uno sport così complesso?
Sasso: Quando sono stato convocato la prima volta ad un raduno con la nazionale italiana di para triathlon nel 2013, avevo da poco realizzato il record del mondo di maratona con le stampelle. Sapevo nuotare solo per fare il bagno, perché io che sono di Ischia e considero il mare uno dei miei habitat naturale. Nuotare per fare 750 metri è però tutt’altra cosa, è servito tanto superare le mie difficoltà dal punto tecnico sia nel nuoto che nel ciclismo essere seguito da un preparatore specifico per le due discipline. La prospettiva che mi avevano dato nel 2013 era la qualifica per le olimpiadi di Rio del 2016! Mai nessun Ischitano era riuscito a qualificarsi per una Olimpiade. La motivazione di raggiungere un obiettivo così impegnativo, ma anche così prestigioso, mi ha fatto superare ogni ostacolo. Era così forte il mio focus a Rio 2016 che quasi non sentivo il carico degli allenamenti.
F.T.: Le pressioni, volente o nolente le trovavi in casa
Sasso: Sicuramente lo scotto più grande è stato allontanarmi da casa, dalla mia famiglia, dal mio territorio e dal mio amore, ma la pressione si è trasformata in sostegno da parte di un’intera isola che vedeva in me la realizzazione di un sogno per l’intera comunità. La partecipazione alle olimpiadi di un figlio di Ischia è stata la spinta più forte, mi sono sempre sentito sollevato dai miei compaesani e volevo renderli orgogliosi di me. Mi trasferii quindi a Piacenza per allenarmi meglio.
F.T.: Non hai mai avuto il desiderio di andare oltre ai tuoi limiti?
Sasso: Quando mi è successo l’incidente io, che vivevo nell’epoca di Maradona e Platinì, nel periodo d’oro del calcio italiano, il mio desiderio più grande era quello di provare a giocare a calcio a livello professionistico. Quando stavo nel letto dell’ospedale, io non pensavo che non avrei più camminato come tutti quanti, ma pensavo solo che non avrei potuto giocare a calcio. Quando ho poi realizzato che con le stampelle potevo giocare a calcio, potevo correre, bè lì ho capito che ogni mio limite si trasformava in un obiettivo da raggiungere. Sempre più avanti puntavo l’asticella e sempre la voglia di riuscire mi ha faceva superare ogni difficoltà.
F.T.: Da parte della comunità locale che messaggio hai ricevuto dopo la tua scesa in campo?
Sasso: Il forte sostegno della comunità di Ischia è per me qualcosa di forte, di autentico. Un messaggio di solidarietà, comprensione e forza. La partecipazione a Rio 2016 è stato un riconoscimento reciproco tra me e l’isola di Ischia. Tanto avevano creduto in me per la qualifica che tanto mi sentivo orgoglioso per ciò che avevo fatto.
F.T.: Da quando hai iniziato la carriera di paratriathleta ci sono stati anche momenti difficili legati ad infortuni?
Sasso: Il momento più difficile è stato legato all’impianto di una protesi per correre più velocemente la frazione di corsa. Il dolore delle lacerazioni sono stati fortissimi, le mie mani dopo ore di uso delle stampelle erano una bolla unica di sangue che poi si è trasformata in un unico callo che mi permetteva di non sentire più alcun dolore. Io credo che se vuoi raggiungere qualcosa, ogni modo che hai per ottenerla sia un ausilio. Il mio motto è: “usa quello che hai e raggiungi quello che vuoi!”.
F.T.: In che modo e quanto il triathlon è la tua vita ora?
Sasso: Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Rio, il triathlon non è più il mio stile di vita, ma è uno sport che pratico che mi ricorda dei passaggi personali stupendi e mi piace sempre molto.
F.T.: Quali sono state le doti che hai visto “crescere” e che non avevi messo in preventivo?
Sasso: La mia grinta, la mia volontà e la mia voglia di imparare e ascoltare i professionisti di supporto e i tecnici di riferimento. Non partecipi ad un’olimpiade se non hai i preparatori competenti che ti seguono, ma nemmeno se non hai la capacità di ascoltare e crescere nella tua personale preparazione.
F.T.: Quale spazio per una nuova possibilità di crescita?
Sasso: Io oggi faccio il motivatore e porto le persone a credere in loro stesse e a raggiungere i propri obiettivi. Lo sport è per tutti, lo sport è di tutti!