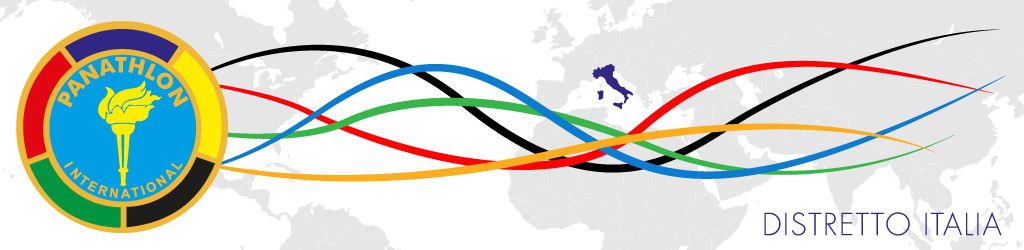La vittoria di un outsider nei 10.000 metri di Ron Clarke
-Adalberto Scemma–
Robot che accolgono i turisti all’aeroporto, telecamere biometriche per l’identificazione delle persone, software per la traduzione linguistica simultanea, veicoli alimentati a idrogeno e taxi (ma sarà poi vero?) che gireranno per Tokyo senza autista. Le Olimpiadi in arrivo saranno le più tecnologiche di sempre, con il Giappone pronto ancora una volta a fare dell’innovazione il proprio punto di forza. Era già accaduto nel ’64, allorché in occasione dei Giochi apparvero per la prima volta i treni monorotaia Shinkansen, in grado di toccare i 400 km. orari. Stavolta si andrà addirittura oltre: sono già pronti i treni Maglev a levitazione magnetica, sperimentati ben oltre i 600 km. orari.
Tokyo 1964
Dal ’64 a oggi sono passati 56 anni, più di mezzo secolo. Se affido al rewind il nastro del tempo ritrovo storie che all’epoca neppure sognavo, storie appese allora a troppe virgole d’utopia: la passeggiata lunare di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, la rivoluzione dell’informatica, il boom degli smartphone oppure, per rimanere nello sport, l’impiego di materiali mai supposti, dalle biciclette al titanio alle vaporfly di Eliud Kipchoge, dalle gallerie del vento alle piste di atletica in sintetico. Ma ritrovo anche, più coinvolgenti, le immagini di cose e persone che hanno accompagnato le vicende sportive di cui sono stato testimone o coprotagonista. A partire proprio da quella Olimpiade, vissuta così intensamente dagli atleti azzurri (l’oro di Pamich, il bronzo di Morale, l’argento nell’inseguimento dei nostri Roncaglia e Mantovani) con appendici emozionali destinate a coinvolgere gli storici portacolori della Libertas, dai tre fratelli Pizza ad Andrea Pedroni, da Riccardo Darra a Maurizio Bacchi fino a Gianni Truschi. Dopo l’epopea di Roma ’60 furono proprio le Olimpiadi giapponesi a fungere da spartiacque per gli atleti mantovani, usciti dalla fase pionieristica e lanciati verso un decisivo salto di qualità grazie anche alle proposte innovative che Tokyo cominciava a distribuire.
A rivederla oggi nei filmati d’epoca la pista in terra rossa del “Kokuritsu”, lo stadio olimpico di Tokyo ’64, sembra appartenere a un altro mondo. Quattro anni più tardi, a Città del Messico, sarebbe cominciata la rivoluzione del tartan a innescare un cambio radicale di strategie negli allenamenti con la possibilità di correre e di saltare anche d’inverno. Quelle di Tokyo passarono quindi alla storia come le ultime a dimensione “prevalentemente umana” con qualche insondabile balzo nel futuro, come i 10” netti realizzati da Bob Hayes sui 100 metri o la doppietta di Peter Snell negli 800 e nei 1500, impresa mai più realizzata e con un unico precedente (l’inglese Albert Hill ad Anversa 1920).
Era l’epoca della tivù in bianco e nero, i teleschermi misuravano mediamente 14 pollici ma ci tenevano incollati in full immersion, durante l’Olimpiade, con febbrile partecipazione emotiva. E tuttavia proprio quella pista in terra rossa ci regalò una gara talmente imprevedibile da rappresentare, anche a distanza di tanto tempo, l’evento più “straordinario e sconvolgente” nella storia della corsa: la vittoria a sorpresa di Billy Mills, un underdog, un perdente designato, neppure inserito tra gli outsiders, su una distanza, i 10.000 metri, fino ad allora riservato dominio di fuoriclasse leggendari, da Paavo Nurmi a Ville Ritola, da Emil Zatopek a Vladimir Kuts.
I 10.000 metri
Favorito d’obbligo, per pronostico unanime, era l’australiano Ron Clarke, 23 primati mondiali demoliti in carriera su tutte le distanze, dalle 2 miglia sino all’ora di corsa. Capace di macinare chilometri senza mai diminuire l’andatura ma con un unico handicap: la mancanza di spunto finale. Un turbodiesel della pista. Chi riusciva a stargli dietro (problema quasi sempre irrisolvibile!) poteva soltanto sperare di batterlo in volata. E proprio la volata, il kick finale, il “calcio di mulo”, lo sprint beffardo sul rettilineo d’arrivo, era la chance che i pronostici attribuivano all’unico possibile avversario di Ron Clarke: Mohammed Gammoudi, tunisino, apripista della straordinaria scuola di mezzofondo del Maghreb.
Fu una gara condotta in apnea anche dagli spettatori. Ron Clarke subito in testa, Gammoudi a francobollo, un metro dietro, l’etiope Mamo Wolde a inserirsi per spezzare il ritmo. E a sorpresa l’americano Billy Mills, un carneade, teso invece a tenerla elevata l’andatura, capace di sopravanzare a tratti addirittura Clarke. Corsa tiratissima fino all’epilogo fuori copione, dopo un ultimo giro “alla morte” tutto in accelerazione: il crollo di Mamo Wolde, l’allungo troppo flebile di Clarke, il guizzo in apparenza decisivo di Gammoudi, schizzato via sull’ultima curva, e l’irreale, stordente ingresso a catapulta di Billy Mills sul rettilineo finale, quindici-venti metri recuperati a Clarke prima di infilare Gammoudi sul traguardo con un “calcio di mulo” senza respiro. Nessun atleta americano aveva mai vinto alle Olimpiadi una gara di mezzofondo prolungato: Billy Mills (ma chi era costui?!) apriva così una pagina storica.
Billy Mills
Essenziale, persino troppo essenziale, la biografia battuta dalle agenzie di stampa: 26 anni, tenente dei Marines, specialista della corsa campestre, approdato da poco alle gare su pista. I giornalisti americani non ne sanno di più. Finché qualcuno non rivela un particolare inedito e di evidente interesse cronistico: Billy Mills è un pellerossa Sioux della tribù degli Oglala Lakota, la stessa di “Crazy Horse”, il mitico Cavallo Pazzo. Una tribù di guerrieri acculturati e in odore di sciamanesimo, studiati anche in chiave favolistica dai cultori dell’ethos. È un assist che i media di tutto il mondo recepiscono enfatizzandolo. Da un lato l’alone prevedibile da leggenda che circonda, per gli appassionati dei western, il “popolo rosso”, dall’altro la storia personale a tutto tondo di Billy Mills, nato nella riserva indiana di Pine Ridge, da sempre in prima linea per il riconoscimento dei diritti della sua gente. Quanto basta a farne un eroe nazionale, impeccabile (e persino ascetico, nell’applicazione della sofisticata filosofia dei nativi americani) nei successivi comportamenti di vita. Una storia emozionante, la sua, trasferita poi in un film di successo (“Running Brave”) interpretato da Robby Benson.
***
Quando lo incrociammo alla “Cinque Mulini” (28 marzo 1965, sei mesi dopo l’Olimpiade di Tokyo) Billy Mills era già leggenda. La “Cinque Mulini”, memento, è ancora oggi la corsa campestre più famosa del mondo, con un albo d’oro che raccoglie il Gotha dei vincitori d’Olimpia. Si corre dal 1933 a San Vittore Olona con un’unica differenza rispetto alla fase iniziale: i mulini al cui interno si incuneano i corridori non sono più cinque ma tre; chi guarda le acque gialle di schiuma e puteolenti dell’Olona, il “fiume madre” di Gianni Brera (il padre è il Po) non ha bisogno di chiedersi il perché. Ma siccome Mulini, in inglese, si dice proprio Mills, ecco che cinque o tre, per Billy, non doveva fare differenza.
A rappresentare la Libertas Mantova tra i 120 corridori invitati alla “Cinque Mulini” non c’erano i fratelli Pizza e Andrea Pedroni, alfieri tradizionali, ma Riccardo Darra, non ancora ventenne, e il vostro cronista, che di anni all’epoca ne faceva 22. Per noi si trattava del debutto internazionale in una gara da brividi. Accanto a Mills c’era la Nazionale jugoslava al completo con Franjo Mihalic, argento olimpico a Melbourne, tre ori alla “Cinque Mulini”, vincitore delle maratone di Boston, Atene e Mosca e della Corrida di San Silvestro a Rio de Janeiro, e poi Cervan, Vazic, Bogunovic, Hafner, Jovanovic, Kovac, Stros, vado a memoria, gli inglesi Freary e Johnston e naturalmente gli azzurri Conti, Ambu, Rizzo, Volpi, Bianchi, Begnis, il meglio insomma dei corridori di lunga lena.
Una presenza, quella di Riccardo Darra e la mia, puramente simbolica dal punto di vista agonistico: un’occasione straordinaria, tuttavia, per fare esperienza e per mettere a fuoco (Riccardo in particolare, che detiene ancora oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, il record mantovano dei 10.000 metri!) la differenza – e quale differenza! – tra noi e i campionissimi.
Abbiamo corso al fianco di Billy Mills durante il riscaldamento, non in gara. In gara gli abbiamo sempre visto, e da molto lontano, soltanto le spalle. Gli abbiamo chiesto di Tokyo e di quella forza misteriosa che era sembrata esplodergli dentro all’improvviso. “Quella forza -ecco le sue parole- era la mia “indianità”. Ho pensato a “Crazy Horse”, a Cavallo Pazzo, e a come i nostri grandi capi continuavano a combattere quando tutte le condizioni erano contro di loro. Negli ultimi metri della corsa non ero Billy Mills, ero Makata Taka Hela, il mio nome nella lingua dei Lakota. Vuol dire: Ama la tua terra. Dovevo crederci, tentare l’impossibile, non potevo deludere la mia gente”.
Correvamo in allungo ma la sua era una corsa in totale decontrazione. Non sentivamo neppure il rumore dei suoi passi, quei passi che sembravano cadenzati su impercettibili variazioni, come di spazzole jazz. Billy Mills aveva un’eleganza motoria indefinibile, si adattava con naturalezza al terreno che cambiava: l’erba livellata del prato, l’impasto granuloso della pista, la sabbia umida della buca dei salti, una salitella improvvisa. E chissà che non fosse proprio questo uno dei tanti segreti dei pellerossa, il segreto di quei “felpati passi silenti” enfatizzati dai film western.
Ultimi allunghi, ancora pochi minuti poi la “Cinque Mulini” avrebbe preso il via. E sarebbero stati il piacere della corsa, ma anche la fatica della corsa, a farci compagnia. La stessa idea della fatica che Billy riuscì a cancellare dalla mente, a Tokyo, prima dello sforzo finale. “I Lakota -disse- pensano per immagini e le immagini sono un supporto spirituale. Durante l’ultimo giro, mentre doppiavo un corridore tedesco, vidi l’insegna di un’aquila sulla sua maglia. Mi ricordai allora le parole di mio padre in un momento di difficoltà: “Ora le tue ali sono rotte ma un giorno avrai le ali di un’aquila”. Mi piace pensare che siano state quelle ali, come un segnale sciamanico, a farmi vincere l’Olimpiade.”
A colpirmi, una sensazione questa riaffiorata nel tempo, è stata soprattutto quella vibratile atarassia, dovete consentirmi l’ossimoro, risultata poi determinante nell’ispirare l’azione di Billy Mills in favore delle riserve indiane. Il “popolo rosso” aveva fatto del movimento, del rispetto per la natura e della mentalità guerriera la propria ragione d’essere senza mai smarrire, neppure nei momenti di più cupa compressione, la propria dignità. E qui ha avuto buon gioco, nella protesta del campione olimpico, la capacità di usare con sapienza la carta della tutela culturale, una risorsa che ha fatto di Mills, negli anni a venire, una sorta di eroe americano. È ancora presente nei libri di testo delle scuole primarie una sua frase diretta ai bambini della riserva indiana di Pine Ridge: “Inseguire i tuoi sogni ti aiuterà a rimarginare le ferite”.
Billy Mills vinse la trentatreesima edizione della “Cinque Mulini” senza sforzo apparente, correndo ad anca bassa con il minimo dispendio energetico. I saliscendi della campestre erano da sempre il suo terreno preferito. Freary, Vazic e Mihalic si sfilarono lentamente ma inesorabilmente nell’ultimo giro, gli azzurri brindarono piazzando Conti (quarto) Ambu (ottavo) tra i primi dieci. Un risultato positivo se si considera che negli ultimi sessant’anni soltanto tre italiani figurano nell’albo d’oro della “Cinque Mulini”: Gianfranco Baraldi (1960), Antonio Ambu (1964) e Alberto Cova (1986).
Riccardo Darra bagnò l’esordio con un indice positivo chiudendo la corsa in posizione centrale. Io patii lungo i dieci chilometri e passa del percorso le pene dell’inferno dopo un agile avvio e chiusi con la bava alla bocca, ma questo è un altro discorso…
***
Furono Billy Mills e gli altri campioni della “Cinque Mulini”, dunque, ad accompagnare il debutto della Libertas Mantova in una corsa campestre internazionale. Fu quello il passaporto per un futuro atletico non più limitato al Migliaretto o alla pista del Campo scuola. Le edizioni successive videro infatti la presenza pressoché costante di Michele, Giovanni e Antonio Pizza, di Andrea Pedroni, Riccardo Darra e Maurizio Bacchi e, più avanti nel tempo, di Gianni Truschi. Occasioni spesso straordinarie per confrontarsi in diretta con fuoriclasse di caratura mondiale. E non mancarono incontri carichi di emozione, come quelli con i leggendari Kipchoge Keino e Lasse Viren, John Walker e Filbert Bayi, Akii Bua e Frank Shorter, Gaston Roelants e Naftali Temu.

Soltanto sfiorato il confronto con il grande Ron Clarke, corridore da record ma sempre sconfitto nei grandi appuntamenti, sfortunato anche in occasione della “Cinque Mulini”. Era il 1966, l’anno successivo alla vittoria di Billy Mills. Proprio alla vigilia Clarke venne colpito dall’influenza, la febbre a 39° gli impedì di scendere in gara e a vincere fu un inglese, Turner. Gli fecero dare il via, povero Ron, con due coperte di lana sulle spalle e una berretta peruviana in testa. Sudava freddo e batteva i denti, lui che aveva in bacheca 23 titoli mondiali, ma cercava goffamente, disperatamente, orgogliosamente, di sorridere. Les dieux s’en vont? Non subito. Clarke proseguì proprio in quella stagione la frenesia dei record esaltanti e delle sconfitte cocenti. E a Città del Messico, tre anni più tardi, concluse la sua avventura di perdente di successo inchinandosi a Gammoudi nei 5000, a Temu nei 10.000 e all’eterno Mamo Wolde, un antenato all’anagrafe, nella maratona che segnò l’addio di Abebe Bikila.